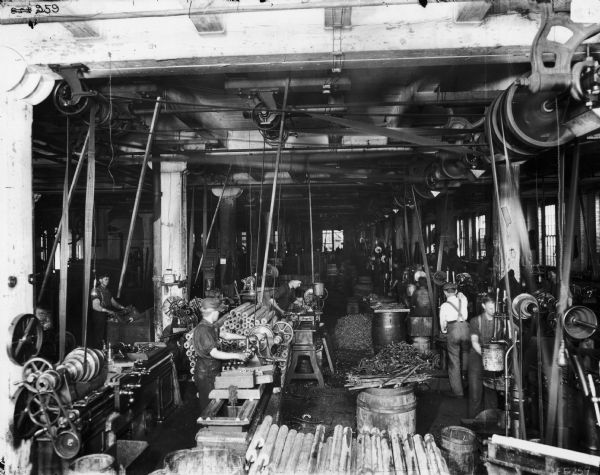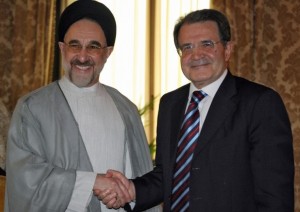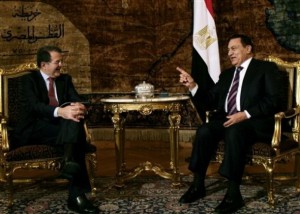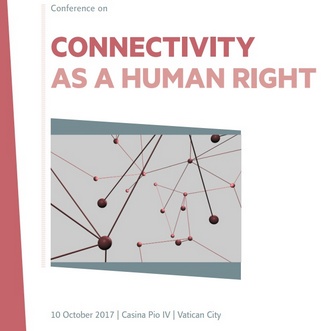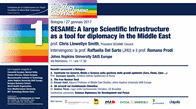Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 20 settembre 2009
Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 20 settembre 2009
Si discute tanto e si fa tanto poco per l’Africa. Il grande “continente nero” continua infatti ad essere oggetto e non soggetto della politica mondiale. Quando nascono conflitti così tragici da contare i morti a centinaia di migliaia come in Ruanda, Sudan o Somalia l’opinione pubblica si commuove e per un po’ di tempo si mobilita. Poi tutto viene dimenticato, lasciando alle poche migliaia di soldati delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana l’impari compito di gestire le sanguinose conseguenze di queste guerre, così come alle associazioni non governative e ai missionari di fare fronte alla tragedia quotidiana dei più diseredati. Intanto le vendette e gli assassini continuano senza sosta e senza nemmeno avere l’onore della cronaca.
Ormai le guerre africane non sono guerre tra Stati, ma fra etnie, gruppi tribali o semplicemente per bande armate che si schierano ora con i governi ora contro i governi. È una storia infinita, che da decenni vede i conflitti diffondersi da Paese a Paese attraversando i confini artificiali tracciati in passato dalle potenze coloniali senza tener conto di etnie, religioni, caratteristiche geografiche e risorse naturali. In questo quadro ogni grande potenza adotta una sua “politica africana” costruendo rapporti bilaterali con i Paesi a lei legati: la Francia con i Paesi francofoni, la Gran Bretagna con quelli anglofoni, gli Stati Uniti soprattutto con i Paesi petroliferi del West Africa, mentre la Cina adotta una politica veramente continentale, curando relazioni intense con la quasi totalità dei Paesi africani, cioè cinquanta su cinquantatré. Il tutto in una logica prevalentemente bilaterale cioè da Paese a Paese. Il che significa, dal punto di vista economico, impedire ogni possibilità di sviluppo futuro di tutti i Paesi africani che, da soli, non raggiungeranno mai la forza e le economie di scala per costruire strutture capaci di competere con il resto del mondo.
Nemmeno le più grandi nazioni del continente come l’Egitto, il Sud Africa e la Nigeria hanno la dimensione sufficiente per costruire una solida economia nazionale. Il commercio tra i Paesi dell’Africa è minimo (raggiunge solo il 10 % del loro commercio estero totale) perché mancano infrastrutture, accordi ed istituzioni che li leghino tra di loro. Dal punto di vista politico la rigorosa applicazione del concetto statuale ereditato dalle potenze coloniali impedisce di tener conto delle realtà più complesse, come le tribù, le etnie, le appartenenze religiose o i tradizionali rapporti o interessi consolidati nei secoli. Per far fronte a questo è nata l’Unione Africana che, raccogliendo tutti i 53 Stati africani (eccetto il Marocco) tenta con fatica di costruire una unità politica ed economica del continente. È un’unione imperfetta, embrionale e con poteri limitati ma è tutto ciò che il continente può preparare per organizzare il proprio futuro, anche per l’indubbia qualità di alcuni suoi leaders. Le grandi potenze sono però riluttanti a riconoscere ed aiutare questa realtà (solo la Commissione europea lo ha fatto) e non ritengono mai prioritaria la necessaria collaborazione tra i Paesi africani.
Anche nel delicato settore del peace -keeping soprattutto la Francia e la Gran Bretagna sembrano fare resistenza a dotare l’Unione Africana dei mezzi e dell’assistenza necessaria perché possa progressivamente contribuire a costruire e a mantenere la pace nel continente.
La motivazione di questa politica è che l’Unione Africana non è ancora pronta a svolgere questo compito. Ciò è certamente vero ma essa non sarà mai pronta se non riceve fiducia, mezzi, assistenza e aiuto per raggiungere questo obiettivo. Siamo insomma in un dilemma apparentemente senza soluzione: da un lato si deve constatare che l’Unione Africana non può, allo stato attuale, svolgere il compito di promuovere la convivenza e lo sviluppo degli Stati africani, mentre dall’altro, le tradizioni e gli interessi del passato non permettono che essa progredisca in questa direzione.
In tale quadro il presidente Obama si presenta come la nuova speranza. Ha fatto discorsi splendidi sull’Africa sia al Cairo che in Ghana, ha scelto inviati speciali molto più saggi e flessibili dei precedenti come il generale Gration per il Sudan, ma non ha ancora preso alcuna decisione concreta nel segno del cambiamento. Non c’è ancora una nuova politica americana per l’Africa.
Intanto la crisi economica morde l’Africa in modo ancora più violento di quanto non si prevedesse, esasperando ulteriormente le tensioni e la spinta verso l’immigrazione.
Non si può continuare a biasimare la Cina per la sua eccessiva presenza in Africa (presenza che costituisce per molti aspetti un’opportunità) senza proporre, insieme alla stessa Cina, una nuova e diversa politica. Una politica che tenga conto delle diversità e degli interessi comuni, dei nuovi ruoli che debbono giocare le etnie, le tribù e le appartenenze religiose. Una politica che, nello stesso tempo, preveda un rafforzamento dei compiti e dei poteri dell’Unione Africana.
Gli aiuti economici e l’assistenza umanitaria sono indispensabili, ma non bastano. Per costruire la pace e la collaborazione tra i diversi Paesi del continente africano occorrono nuovi strumenti politici.