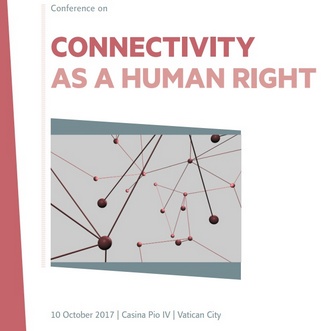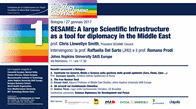La strategia USA. Più cervello meno muscoli nella guerra al terrorismo
La strategia USA. Più cervello meno muscoli nella guerra al terrorismo
Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 21 settembre 2014
All’inizio del secondo mandato Obama aveva concentrato l’attenzione della sua politica estera sulla Cina e sulle aree circostanti. Tutto il resto era secondario. L’Ucraina non era ancora arrivata ad un livello intollerabile di tensione e il Medio Oriente sembrava perdere l’importanza prioritaria che aveva avuto in passato. Gli esperti di politica internazionale pensavano inoltre che quest’importanza sarebbe ulteriormente diminuita. Essa si era infatti sempre fondata su due pilastri indiscutibili: la protezione di Israele e la garanzia del rifornimento energetico per gli Stati Uniti.
Il primo obiettivo, anche se con un minore entusiasmo, rimaneva e rimane ma il secondo è uscito rapidamente dall’agenda, dato che le nuove risorse di shale-gas e di shale-oil stanno portando gli Stati Uniti verso un’indipendenza energetica nemmeno immaginata in passato. Un evento che non solo rafforza enormemente l’economia americana ma che sta producendo una diminuzione dei prezzi mondiali del petrolio pur in presenza di gravissime tensioni in molti Paesi produttori. Un calo di prezzi che, se continuerà in futuro, metterà a dura prova anche l’economia russa, che ancora fonda una parte prevalente del bilancio dello stato e del commercio estero su gas e petrolio.
A distanza di pochi mesi lo scenario è quindi cambiato.
I problemi dell’Oceano Pacifico sono ancora sul tavolo ma per ora non sono prioritari: le tensioni fra la Cina e i Paesi limitrofi (a cominciare dal Giappone) rimangono molto elevate ma si manifestano per ora più in espressioni verbali che non in atti di concreta ostilità. Come se la Cina e gli altri Paesi dello scacchiere asiatico si fossero resi conto che le loro priorità sono ancora legate allo sviluppo economico e che quindi conviene raffreddare le tensioni o, addirittura, aprire nuovi canali di collaborazione, come sta avvenendo fra India e Cina.
Tutto questo non vuol dire che la competizione fra Cina e Stati Uniti non rimanga la grande sfida del nuovo millennio. Significa solo che la gara è stata rinviata perché, per il momento, prevalgono altri problemi ed altri interessi.
Il Medio Oriente è infatti di nuovo in prima linea non più per il petrolio ( almeno da parte americana) ma per il ritorno dei sanguinosi conflitti ereditati dalla guerra in Iraq e dagli innumerevoli errori della passata politica, errori che hanno contribuito a dare vita ad un evento nuovo ed imprevisto, cioè la nascita del terrorismo con base territoriale. Un terrorismo che si fa Stato.
Tutti siamo al corrente di quanto sia pericolosa questa evoluzione e come grande sia la preoccupazione per una sua possibile espansione verso molti altri territori.
Minore riflessione è stata invece dedicata al modo con cui gli Stati Uniti sono costretti ad affrontare questa nuova sfida.
Non certo scendendo di nuovo sul campo di battaglia. Prima di tutto perché l’opinione pubblica americana è stanca di combattere. Nel dibattito politico interno vi è ancora chi preferisce mostrare i muscoli ma, nella realtà dei fatti, nessuno è disposto ad assistere di nuovo alle cerimonie di ritorno delle salme dei soldati caduti nel lontano ed incomprensibile fronte del Medio Oriente.
Non essendo più in grado di pagare quest’altissimo prezzo, si usano strumenti meno rischiosi ma anche meno efficaci, come i bombardamenti aerei e il crescente rifornimento di armi alle coalizioni ( più o meno amiche) disposte a combattere il terrorismo. Si è, a questo proposito, chiesta la collaborazione ad una quarantina di Paesi e in primo luogo ai governi europei, che hanno reagito in modo cooperativo ma estremamente prudente, anche se la Francia si è più degli altri esposta inviando i propri jet a bombardare le postazioni dell’ISIS. Ancora più prudente è stata la reazione dei Paesi arabi “amici”, alcuni dei quali continuano a mantenere un elevato livello di ambiguità anche di fronte a questa nuova espressione dell’estremismo islamico.
Nonostante questi comportamenti prudenti la nuova strategia di Obama si dedicherà sempre di più a chiedere un crescente impegno militare ai suoi alleati, impegno che, nel caso europeo, difficilmente potrà materializzarsi fino a che non ci sarà una politica estera comune.
Oltre all’interrogativo sulla risposta iraniana tre sono i maggiori ostacoli perché quest’accordo possa essere raggiunto.
Il primo, del tutto ovvio, è quello di convincere l’opinione pubblica americana. Dopo tanti decenni in cui l’Iran è stato etichettato come il grande Satana non si tratta certo di un passaggio indolore.
Il secondo ostacolo, anch’esso non facile da fare digerire, riguarda la paura di Israele di essere abbandonato dall’ombrello protettivo americano. Senza questa riassicurazione difficilmente un qualsiasi accordo potrà andare in porto. Il terzo ostacolo si esprime nella necessità di concludere il trattato nucleare con l’Iran in accordo con la Cina e la Russia.
Inutile dire quanto questo sia difficile perché, anche se sbagliando, Russia e Cina possono pensare di avere interesse a tenere gli Stati Uniti impantanati ancora a lungo nel Medio Oriente. Oggi, tuttavia, quest’accordo è possibile perché il nuovo terrorismo minaccia di espandersi ovunque e quindi fa paura a tutti, a partire dalla Russia e dalla Cina.
Resta tuttavia fermo che, senza la firma di Russia e Cina, né l’opinione pubblica americana né Israele possono sentirsi rassicurati.
Un fatto è quindi certo: la politica americana si sta allontanando sempre di più dalle solitarie prove di forza per fondarsi sulla diplomazia, le alleanze e gli accordi. Il soft-power e il cervello si sostituiscono progressivamente ai muscoli.
Solo con questa strategia Obama potrà affrontare con possibilità di successo anche la sfida con la Cina che, come egli stesso ha dichiarato, sarà il punto di riferimento della politica del secolo che stiamo vivendo.
Non avendo per ora alcuna prospettiva che a questa grande gara partecipi l’Europa, ci limitiamo a sperare che questa sfida sia pacifica.